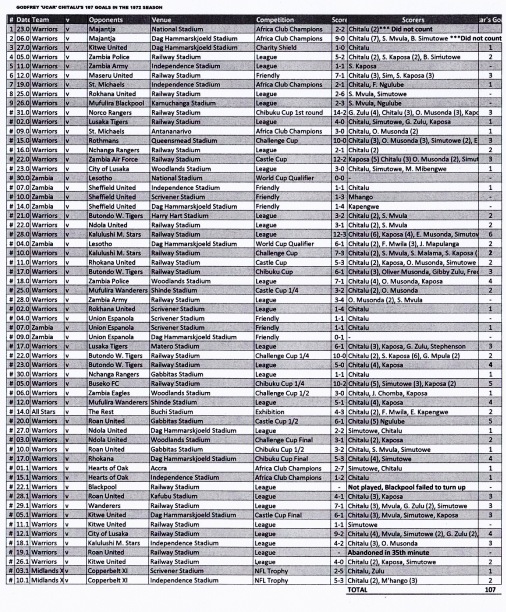Traducir en español [Google Translate] Translate in English

Lo Spogliatoio ospita temporaneamente la casa editrice Panoptikon; se gradite i contenuti potete seguire l’attività di questa nuova inziativa e supportarla su Facebook e Twitter.
Il rugby è lo sport dei veri uomini, onesti e generosi; il calcio è lo sport dei ricchi viziati, venduti e simulatori. Il rugby è letteratura, un grande classico; il calcio è spazzatura, un instant book.
Abbiamo chiesto a tre dei più validi autori che quotidianamente si occupano di rugby un parere sulla differente percezione di rugby e calcio che permea la vulgata. Una differenziazione totale, massimalista, ontologica: il rugby è purezza, il calcio è sporcizia. Sarà vero? Cerchiamo di gettare un raggio di luce su miti, archetipi, verità, menzogne e banalità che affliggono il discorso comune sul rugby.
Hanno gentilmente risposto:
– Duccio Fumero, curatore del blog Rugby 1823 ospitato da Blogosfere (e tante altre cose).
– Davide Macor, vulcanica mente di Non Professional Rugby (e tante altre cose).
– Elvis Lucchese, uno dei più validi scrittori di rugby (e tante altre cose).
Un luogo comune tutto italiano vuole che il rugby e i rugbisti siano “diversi” da calcio e calciatori. I primi vengono percepiti come atleti leali, colti, “puliti” e “sportivi”, mentre i secondi sono imbroglioni, furbi, simulatori, ignoranti e rappresentanti di un’Italia stereotipata e retrograda. Addirittura gli sport stessi assurgono a paradigma di questi valori e comportamenti. Cerchiamo di mettere in chiaro quali delle differenze percepite sono reali: in quali aspetti a tuo avviso c’è una vera differenza tra i due sport e i loro praticanti?
Fumero: Nasce prima l’uovo o la gallina? La domanda classica torna prepotente anche quando si cerca di paragonare il rugby al calcio, i suoi valori con i disvalori che, ormai, spesso accompagnano la palla tonda. Ma il rugby è veramente superiore al calcio per dna? O i rugbisti sono superiori ai calciatori? O, invece, è l’ammantare il rugby di questi valori e di questa capacità etica e istruttiva a renderlo, nel tempo, più appetibile a chi è eticamente superiore? Secondo me tra i due sport non vi sono, di fondo, reali differenze. Alla base. È stato il tempo, il professionismo, le derive, la difesa di certi valori ad ampliare la forbice tra rugby e calcio. Una forbice che rischia di allargarsi ancora, proprio perché la percezione del rugby come sport “pulito” porta ad avvicinarsi al gioco chi viene da famiglie con valori etici superiori e una classe socioculturale medioalta.
Macor: Allora differenze ce ne sono, questo è sotto gli occhi di tutti. A mio parere, però, negli ultimi anni si è “mitizzato” troppo il rugby, a discapito proprio dell’immagine “pura” con cui era arrivato sui “grandi palcoscenici”. L’unica vera differenza tra i due sport, a mio parere, sta in certi aspetti che rendono la palla ovale più alla portata di tutti, rispetto al calcio, sport bellissimo, ma gestito da persone maggiormente interessate ai propri interessi, piuttosto che al bene dello sport e degli sportivi. Sostanzialmente, poi, la differenza tra calciatori e rugbisti, fuori dal campo da gioco, sta nei soldi: il “vil denaro”, cambia persone e comportamenti. L’errore a questo punto, come in tutte le cose, è quello di fare “di tutta l’erba un fascio”; non tutti i calciatori sono sbruffoni, come è vero che non tutti i rugbisti sono dei simpaticoni, ma questo penso sia una cosa normale, in ogni aspetto della vita.
Lucchese: Il rugby è uno sport di intensi scontri fisici e il rispetto delle norme che regolano la violenza è indispensabile – come ad esempio nel pugilato – per garantire l’incolumità dei partecipanti, per limitare l’aggressività e per evitare la degenerazione alla rissa da saloon. Il rugby ha potuto conservare quella marcata etica vittoriana che originariamente aveva in comune con il “fratello” football grazie ad una diffusione nel mondo in fondo limitata e soprattutto grazie al ritardo – di quasi un secolo rispetto al calcio – nell’adozione del professionismo vero e proprio. L’approdo al paradigma rugby/fair play in opposizione al calcio/frode è ovviamente un passaggio indebito, una ingenua semplificazione. Si tratta peraltro di una interpretazione del rugby solo italiana, ed anche in Italia sviluppatasi solo di recente parallelamente alla crescita di interesse del grande pubblico maturata dal 2000 (ingresso nel Sei Nazioni) e in particolare dal 2007 (due vittorie azzurre nel torneo). Una interpretazione che secondo me si fa strada in controluce, cioè per definire l’aspirazione di uno sport diverso rispetto al calcio ormai guastato dagli interessi miliardari, piuttosto che da una conoscenza da vicino del mondo del rugby. Va sottolineato che in Italia una percentuale molto bassa del pubblico generico ha praticato lo sport della palla ovale, che nei paesi protagonisti a livello internazionale è invece ampiamente diffuso anche nel sistema scolastico. Nella storia del rugby entra a pieno diritto anche una lunga serie episodi di violenza, di simulazioni, di imbrogli sospetti appurati o sospetti. D’altra parte non è attraverso il fair play che i rugbisti rappresentano il proprio sport, sia in Italia che nel mondo, nè oggi nè in passato. Per i suoi interpreti a definire l’unicità del rugby è invece la sfera ampia della socialità, in altre parole lo spirito di squadra, l’amicizia, il divertimento. Ciò che più balza agli occhi al pubblico generico, il rispetto nei confronti dell’arbitro da parte dei giocatori, è un aspetto intrinseco all’etica che viene tramandata di generazione in generazione e non basta a legittimare lo stereotipo di uno sport “leale, colto e pulito”, ciò che il rugby non è in sé. Nel caso italiano lo spettatore-medio del rugby oggi appartiene ad una classe media di istruzione universitaria e si ben predispone quindi a convalidare l’idealizzazione di uno sport migliore e un po’ speciale (autoconvalidandosi così come gruppo sociale).
In che modo il comportamento delle federazioni internazionali e nazionali (le punizioni e l’entità delle stesse, la tolleranza e l’intolleranza rispetto a certe questioni) e degli arbitri traccia una differenza tra i due sport?
Fumero: In questo solco si inserisce anche una volontà di pulizia che, col tempo, si è resa più forte nel rugby che nel calcio. L’esempio più palese è l’utilizzo del TMO, un’ovvietà nel rugby, ma che il mondo del calcio e chi lo governa non accetta e non vuole. Perché? Difficile a dirsi, ma di sicuro un brutto segnale per uno sport che deve cambiare rotta. Così, nel rugby il rapporto con le polemiche, quindi con gli arbitri e le squalifiche, è molto attento, puntando sulle potenzialità educative dello sport anche a livello professionistico.
Macor: Quello che si percepisce è che al mondo del calcio è concesso tutto e che non c’è assolutamente rispetto per i valori che dovrebbero caratterizzare ogni sport: sportività e disciplina, su tutti. Uno dei fattori, invece, che ho sempre apprezzato nel rugby è che il regolamento è un dogma, un qualcosa che, nonostante tutto, viene seguito ed eseguito alla lettera. L’arbitro in campo è una figura che si può odiare, in ogni caso, però, bisogna rispettarlo e il suo parere, condiviso o meno, è indiscutibile (da ricordare la lezione dell’arbitro gallese Nigel Owens, che redarguiva il mediano di mischia della Benetton Tobias Botes, perché parlava troppo). Il comportamento delle federazioni è in evoluzione costante e gli interventi sulla casta arbitrale con sempre più corsi di specializzazione e aggiornamento sono sotto gli occhi di tutti (sempre più direttori di gara italiani entrano nei ranghi dell’Irb). Bisogna investire tanto sull’aspetto tecnico, quanto su quello arbitrale. Alzando anche il livello degli arbitri, infatti, tutte le partite saranno sempre più piacevoli da vedere e il gioco avrà un ulteriore miglioramento. Una riflessione rispetto al rugby di cui mi occupo, ovvero quello che comprende le categorie di serie B e C, è doverosa: sarebbe opportuno mandare alle partite una terna arbitrale e non l’arbitro da solo. In questo modo, tutti gli incontri, potrebbero essere meglio gestiti e ne guadagnerebbe tutto il movimento.
Lucchese: L’atteggiamento dell’IRB si distingue per un certo dinamismo (di stile molto anglosassone) verso le modifiche regolamentari. Alcune di queste modifiche, come l’adozione della moviola in tempo reale (TMO), vanno nella direzione della massima trasparenza verso il pubblico e gli attori del gioco. Ciò che tuttavia è davvero decisivo nel rapporto fra giocatori e arbitri è il clima di collaborazione presente a vari livelli. Nel rugby professionistico giocatori e arbitri spendono molto tempo lavorando insieme sull’approfondimento e l’interpretazione delle norme del gioco (spesso davvero complesse). La prossimità fra arbitri e giocatori anche nei momenti di aggregazione porta talvolta a relazioni di amicizia, e comunque sempre a rapporti di conoscenza reciproca e ad occasioni di dialogo. Arbitri e giocatori non si vedono quindi in opposizione ma come partner impegnati nella buona riuscita di uno spettacolo. Il fair play è intanto diventato per il rugby italiano e internazionale un importante valore di marketing (le aziende hanno interesse ad abbinare il proprio nome ad uno sport percepito come “pulito” e “leale”). La politica degli organismi che governano la palla ovale sarà dunque sempre più rivolta a rafforzare un’immagine di questo tipo.
Credi che la recente introduzione del professionismo nel rugby incida sulla differenza tra i comportamenti dei rugbisti e dei calciatori?
Fumero: Non credo che il professionismo nel rugby abbia, sostanzialmente, cambiato lo status quo, proprio perché vi è una volontà dell’intero movimento mondiale a difendere le proprie peculiarità.
Macor: Il professionismo nel rugby ha fatto più danni che altro, secondo il mio modesto parere (io ho smesso di divertirmi nel momento in cui i soldi hanno iniziato a “girare”). O per meglio dire, i grandi poteri hanno deciso di passare al professionismo in un momento in cui il movimento si stava evolvendo e non era ancora pronto “al grande salto”; i risultati, poi, parlano da soli. Le franchigie, ad esempio, hanno innalzato l’interesse attorno a questo sport (più che altro la Benetton), ma hanno oscurato e distrutto tutta una serie di campionati minori; vedi Eccellenza e la stessa serie A, che dagli anni in cui ci giocavo anch’io (appena tre stagioni addietro) hanno abbassato il proprio livello in maniera incontrollata. Concludo citando Stefano Benni, cultore del calcio e semplice appassionato di rugby che, in un’intervista che ho avuto la fortuna di fargli, mi congedò dicendomi: «Il rugby sta crescendo (giustamente) nell’interesse dei media, ma non tanto nei risultati… mi sento di consigliare ai ragazzi della nazionale meno foto e più fiato». Riflettiamo…
Lucchese: Il professionismo, a cui è abbinata un’esposizione mediatica assolutamente inedita, sta erodendo l’etica tradizionale del rugby. Da una parte l’esibizione del corpo – ovviamente sconosciuta nel rugby del passato – rientra in codici della virilità che sono radicalmente mutati nella cultura di massa contemporanea, dall’altra oltre che nell’estetica anche nei comportamenti i rugbisti diventano sempre più vicini a quelli dei calciatori. Fino a pochi anni fa, ad esempio, l’esultanza dopo una meta era considerato un gesto inaccettabile, di affronto verso gli avversari. In sostanza si è compiuto il passaggio da “sport per il piacere dei giocatori”, così come è stato inteso il rugby per oltre un secolo, a uno sport rivolto essenzialmente agli spettatori (allo stadio o più spesso davanti alla televisione), come ogni altra disciplina professionistica.
Credi che le federazioni internazionali e nazionali di rugby siano meno “schiave”, anche economicamente, dei loro “campioni”?
Fumero: Più che dei campioni, il problema è il rapporto tra le federazioni e i club, soprattutto in Inghilterra e in Francia dove i due poteri si equivalgono. Nei Paesi emergenti – Italia compresa – il peso della nazionale è ancora troppo forte per permettere a campioni o club di avere più di tanta voce in capitolo.
Macor: Penso che non lo siano. Anche nel mondo del rugby marketing e pubblicità la fanno da padrona e così, di conseguenza, le Federazioni ne traggono inevitabilmente dei vantaggi. Pensiamo all’Italia: perché un non conoscitore di rugby va a vedere il Sei Nazioni, o un test match? Semplice: perché si ricorda delle pubblicità del simpatico Castrogiovanni, delle comparsate tv dei fratelli Bergamasco e dei calendari svestito del buon Parisse. Questa, per un movimento che sta di fatto nascendo, come quello italiano è, senza ombra di dubbio, una fortuna, però mi piacerebbe che le persone non si soffermassero solo a quello e provassero a capire, veramente, cosa vuol dire essere un rugbista. Ad ogni modo, da tutto questo le Federazioni traggono numerosi favori, di sponsor e visibilità; per cui, più in piccolo, possiamo ben dire che sono anche loro schiave dei propri campioni.
Lucchese: Non conosco la situazione di altri sport, ma nel caso del rugby sono spesso i giocatori ad essere schiavi delle federazioni e dei club che costituiscono i loro “datori di lavoro”. Al di là di una ristretta élite di campioni con lucrosi contratti, esiste un gruppo numeroso di atleti professionisti che costituiscono il vero labour dello spettacolo-rugby, che hanno scarse tutele e scarsi diritti in uno sport sempre più logorante dal punto di vista fisico (e con carriere dunque sempre più brevi). E’ ciò che viene chiamata in gergo “carne da macello”: ragazzi, ad esempio, provenienti dalle isole del Pacifico e spremuti nei tornei europei per contratti che comunque non danno garanzie per il loro futuro extrasportivo, esposti al rischio di una interruzione della carriera a causa di un infortunio grave.
Vedendo i due sport dall’esterno sembra che ci sia una netta differenza di introduzione del bambino/ragazzo allo sport: l’approccio al calcio è di tipo professionale sin da quando l’atleta è solo un bambino, mentre il rugby è vissuto più come un passatempo, uno sport che difficilmente “ti dà da vivere”, e di conseguenza lascia più spazio alla vita del bambino/ragazzo. Sei d’accordo? Incide anche questo sulla differente crescita di un calciatore rispetto a un rugbista (e quindi sull’uomo-atleta che sarà)?
Fumero: Sicuramente le aspettative economiche incidono, ma oggi il rugby può dare da vivere, ad alto livello, quindi non è solo questo. Come già detto, la percezione socioculturale, etica ed educativa diversa tra rugby e calcio spinge anche diverse tipologie di genitori ad avvicinare i figli a uno o l’altro sport. Chi in casa viene educato secondo certi valori viene spinto viene determinati ambienti, anche sportivi; chi viene educato secondo altri valori viene spinto verso altri ambienti e altri sport. La crescita mediatica del rugby, abbinata agli scandali calcistici degli ultimi 10 anni, ha portato molti genitori di livello socioculturale medio-alto a “scoprire” la palla ovale e ha fatto crescere il numero di minirugbisti proprio nelle zone più “borghesi” del Paese.
Macor: Io ho iniziato a giocare a rugby alla tenera età di cinque anni e questo sport mi è servito, davvero, come scuola di vita; questa è una frase fatta, ai giorni nostri, ma crescere nel rispetto dei compagni, dell’avversario e percependo il fatto che solo con l’aiuto di tutti e ventidue i giocatori in squadra si potranno raggiungere certi obiettivi, non è cosa da poco. Inoltre il settore propaganda, che se non sbaglio arriva fino all’U14, offre solo concentramenti e non partite ufficiali, per cui si gioca per crescere e non per competere. Poi non bisogna fare di “tutta l’erba un fascio” (ribadisco) perché anche il calcio è uno sport formativo e fondamentale per la crescita di un bambino; però, a volte il miraggio del professionismo dorato crea troppe aspettative e sono gli stessi genitori a non vederlo più come un divertimento, ma come un vero e proprio “lavoro”, perdendo di vista che lo sport da piccoli deve essere solo un divertimento.
Lucchese: Naturalmente i baby calciatori subiscono molte più pressioni di qualunque altro bambino sportivo, ma non vedo comunque alcuna specificità nell’approccio al rugby. Nei club italiani l’avviamento alla palla ovale del bambino è lasciato molto spesso all’improvvisazione (con alcune notevoli eccezioni che però non costituiscono sistema). Sottolineerei invece che i minirugbisti, come tutti i giovani atleti delle altre discipline, sono esposti a tutti i rischi derivati dalla grave mancanza nella nostra società di una diffusa cultura sportiva. Poiché si tratta di una istanza importante per i cittadini tutti, forse dovremmo farci portavoce di un movimento civico che adotti come simbolo la difesa dell’educazione fisica nella scuola italiana, che rappresenta secondo me l’aspetto più drammatico della questione.
Capitolo tifosi: non si sente mai parlare di atti di violenza da parte di tifosi o atleti su un campo di rugby. Accadono e sono accaduti in passato? Quali sono a tuo parere le differenze di mentalità e atteggiamento tra un tifoso di rugby e uno di calcio? Credi che l’ossessione dei media per il calcio incida sull’atteggiamento dei suoi tifosi e credi quindi che la scarsa esposizione mediatica del rugby lo preservi da certi episodi di violenza?
Fumero: Questo, invece, lo vedo come un “falso mito”. La violenza nel calcio ha poco a che fare con il calcio e si rifà più a motivi economici e politici che nulla hanno a che fare con lo sport. Il tifo “caldo” esiste anche nel rugby, ma gli interessi – anche criminali – che ruotano intorno al mondo degli ultras del calcio fanno la differenza che, quindi, poco ha a che fare con i due sport.
Macor: Fatti di violenza possono capitare ovunque, per cui neanche il mondo del rugby ne è privo. Il tifoso di rugby, tuttavia, vive per godersi la partita e “vada come vada sarà un successo”. Il tifoso del calcio, invece, vive per la partita, creandosi aspettative e illusioni che se poi non vengono rispettate gli danno il diritto (secondo quello che vedo) di sfogarsi contro la tifoseria avversaria e tutto quello che li divide. A mio parere il calcio è uno sport bellissimo, che però viene vissuto come un motivo di vita e non, appunto, come una pratica sportiva, un divertimento. I media fanno il proprio lavoro e il calcio, in Italia e nel mondo, è un business per cui l’attenzione è inevitabile, ma questa non è una giustificazione alla violenza negli stadi. Poca attenzione per il rugby? A livello di campionati nazionali forse, ma non ci si picchierebbe comunque (questione di stile); per quanto riguarda la nazionale i numeri dei recenti test match parlano da soli in quanto ad affluenza di pubblico e copertura mediatica, eppure atti di violenza non ce ne sono stati, nonostante l’Italia abbia perso due partite su tre, una anche “per un soffio”. Concludendo penso che, oltre ai tifosi, dovrebbe essere il sistema calcio a cambiare: troppi soldi, troppi benefit, troppi capricci, troppe agevolazioni… se si tornasse a concepire il calcio come uno sport, tutto potrebbe volgere al meglio.
Lucchese: Gesti esasperati dalla rivalità sono accaduti, ma il rugby rimane al riparo da episodi di violenza per motivi ai quali si è già accennato in precedenza: l’etica intrinseca al gioco, la diffusione relativamente scarsa, l’estrazione di classe medio-alta del suo pubblico. La questione, secondo me, andrebbe posta altrimenti, cioè domandandosi perché certi episodi accadono nel calcio (non perché non accadono nel rugby).
Qualcuno di tanto in tanto sussurra che ci siano meno scandali nel rugby poiché le federazioni adottano un atteggiamento “don’t ask don’t tell” quando addirittura non insabbiano questioni scomode. È vero?
Fumero: Questo, ahimé, vale in tantissime federazioni, in Italia e all’estero. Diciamo che, soprattutto, vi è un maggior interesse mediatico nei confronti del calcio che porta la stampa a dare un peso maggiore agli scandali della palla tonda, mentre vi è un disinteresse diffuso verso la “politica” negli altri sport. Scandali, gossip e problemi vengono spesso ignorati più dalla stampa che nascosti dai diretti interessati.
Macor: Rispetto a questa cosa concordo: se nel rugby c’è tanto rispetto e benevolenza per molte cose, dall’altro lato come si suole dire “i panni sporchi si lavano in casa”. Molti eventi negativi legati a questo mondo vengono prontamente insabbiati dalla Federazione di turno, oppure è proprio lo “spogliatoio” (capitano e senatori) a coordinare e risolvere la problematica o lo scandalo, non facendolo nemmeno uscire dalle mura dello stadio.
Lucchese: Non saprei dire se la pratica don’t ask don’t tell sia più o meno presente nel rugby che in altri sport. Il rugby professionistico è sottoposto a pressioni nella misura degli interessi che coinvolge e l’IRB e le varie Federazioni hanno dimostrato spesso di subire il diverso peso politico dei vari partner (si pensi alle scandalose iniquità del calendario dei Mondiali).
Concludiamo in bellezza con il capitolo doping: se ne parla molto nel calcio (in relazione soprattutto ai pochi casi acclarati), mentre nel rugby pare non essere un problema. Assistiamo, però, a sviluppi muscolari e fisici in alcuni casi impressionanti. Qual è la situazione reale?
Fumero: Questo è, forse, il più grave problema del rugby moderno. La stessa Associazione mondiale dei rugbisti professionisti ha attaccato la Wada perché troppo impegnata a lottare contro il consumo di droghe leggere (come la cannabis) a discapito di una vera lotta al doping prestazionale. Il problema doping nel rugby esiste ed è una bomba a orologeria che rischia di esplodere.
Macor: Sinceramente… il doping nel rugby esiste. Possiamo definirlo “mirato”, nel senso che viene praticato fuori stagione, quando i campionati sono fermi e non si hanno strascichi quando le competizioni iniziano. Mi sento di dire solo questo in merito.
Lucchese: La questione del doping, in termini generali, è molto complessa (e, credo, anche molto fraintesa). Sintetizzo per brevità, ma sarebbe necessari ampi approfondimenti. Di certo dove c’è sport professionistico c’è anche il ricorso a farmaci per migliorare le prestazioni fisiche. L’uso di farmaci è diffuso anche nel rugby professionistico, come dimostra peraltro la casistica piuttosto ampia delle positività ai controlli anti-doping, mentre non si può sottovalutare il ruolo protagonista del Sud Africa nello scenario della palla ovale (a causa di un vuoto legislativo il paese è ritenuto uno dei crocevia dei traffici mondiali di sostanze dopanti). L’IRB ha varato il programma “Keep the rugby clean” in linea con l’esigenza – dettata dal marketing – di dare alla disciplina un volto sano e pulito, ma di fatto i controlli nel rugby professionistico restano decisamente blandi. E’ ridicolo che negli ultimi Mondiali i controlli siano stati annunciati pubblicamente in anticipo (eppure hanno fatto registrare un caso di positività). Di fatto nessuna lotta seria al doping verrà mai condotta fintantoché gli interessi del controllore coincideranno con quelli del controllato (e i mezzi a disposizione della Wada sono ancora troppo limitati). Dal mio punto di vista, sono poco interessato a comprendere se il doping influisca sui risultati, mentre la questione più rilevante è invece la nocività per l’atleta. Essendo uno sport professionistico da poco tempo, per il rugby non è disponibile neppure una adeguata casistica per studiare gli effetti a lungo termine dei farmaci sulla salute degli atleti.
L’Editore, ma in massima parte Duccio Fumero, Davide Macor, Elvis Lucchese.